Per uno studio del marxismo
MIGRAZIONI NELL'EPOCA DELLA TOTALIZZAZIONE
Vincenzo Fiano
L’articolo seguente è il Paragrafo 3 del
iv capitolo della
tesi in Filosofia politica intitolata
«L’officina
delle
migrazioni, movimenti migratori e sviluppo capitalistico».
Sia la teoria della totalizzazione
del rapporto di capitale[1]
che l’inquadramento del neoimperialismo come evoluzione dei rapporti
di colonizzazione e imperialismo attraverso la quale il capitale
realizza un allungamento assoluto della giornata lavorativa sociale
su scala mondiale, possono aiutarci nella comprensione delle
motivazioni profonde delle migrazioni ma anche ad estrapolare il ruolo
preciso che i migranti ricoprono in tale sistema. La tendenza del
fenomeno migratorio dai Paesi in Via di Sviluppo (pvs)
ad aumentare e ad avere come meta i Paesi a Sviluppo Avanzato (psa),
può essere spiegata, al di là di tutta la serie di motivazioni comunque
importanti, ma che restano contingenti, come la guerra, le carestie e
tanti altri disastri provocati direttamente o indirettamente dall’uomo,
rinvenendo, ancora oggi, alla base delle migrazioni la regola
principe del capitalismo: la necessità dell’estrazione di
plusvalore. Mentre le colonizzazioni delle fasi precedenti rispondevano
all’esigenza di rinvenire materie prime e, successivamente, anche di
trovare sbocchi commerciali per i propri prodotti, oggi tale estrazione
si effettua prevalentemente attraverso lo scambio di merci in un mondo
interamente capitalistico. Lo scambio diseguale oggi domina i
rapporti internazionali: esso ha sempre rappresentato un pilastro del
rapporto di capitale fin dal livello più concreto del rapporto di lavoro
salariato in quanto la retribuzione non corrisponde al valore realmente
prodotto ma solo ad una parte di esso; un ulteriore livello della sua
applicazione emerge dalla relazione tra città e campagna, ossia dalle
espropriazioni dei contadini che hanno ingenerato il loro movimento
verso le “cittadelle produttive”; le fasi della colonizzazione e del
successivo imperialismo hanno infine creato le condizioni per la
continuazione del ciclo di valorizzazione del capitale così come per una
costante unidirezionalità del valore e della possibilità di
accumulazione che oggi riscontriamo nello scambio diseguale
neoimperialistico. Possiamo a questo punto provare a ricalcare il
profilo che ci interessa in questo quadro: gli odierni migranti sono
innanzitutto vittime di un’espropriazione secolare iniziata da
quando i loro paesi di provenienza, chi prima e chi dopo e con forme
anche molto diverse, hanno visto piegate le proprie possibilità di
sviluppo dall’accumulazione originaria che hanno subito, dalle prime
separazioni tra proprietà e lavoro, da quando il capitale, insomma,
informalmente ma anche con spregiudicatezza, ha colonizzato sempre nuovi
territori. Oggi questi rapporti si sono resi sempre più complessi ma
sono in ogni caso riconducibili alla violenza e alle brutalità delle
spoliazioni con cui il capitalismo ha espropriato le colonie delle loro
ricchezze naturali, ha sottomesso le popolazioni autoctone forzandone
l’ingresso nel mercato del lavoro, ha spazzato via i precedenti
ordinamenti sociali ed economici imponendo le leggi del mercato e
riconducendo in quest’unico sistema i tanti modelli produttivi e i
rapporti sociali ad esso precedenti. Il risultato è la polarizzazione
raggiunta che non si limita più alle materie prime ma si estende «alla
possibilità di produrre cultura, tecnologia e scienza», di concentrarsi
nel «centro del sistema economico mondiale» mediante «la precoce
distruzione, l’arresto o il freno permanente posto all’accumulo delle
medesime precondizioni» necessarie per lo sviluppo delle periferie del
capitale. Posta in questo contesto, la consistente emigrazione schiude
la sua struttura portante e le sue ulteriori caratterizzazioni: «è stata
coessenziale alla costruzione, portata ormai a compimento, del mercato
mondiale, del capitalismo mondializzato, l’utilizzo della forza-lavoro
migrante a basso (o bassissimo) costo e priva di diritti»[2].
Ogni “teoria dello sviluppo” che imputa le disuguaglianze su scala
planetaria ad una fase di passaggio del capitalismo è dunque falsa e
ipocrita; oggi, lungi dall’essersi appianato, il divario tra i paesi
imperialisti più forti e il “Sud” del mondo è sempre crescente e
rappresenta un forte push factor delle migrazioni: «negli ultimi
due secoli il differenziale tra il reddito dei paesi più ricchi e quello
dei paesi più poveri è salito da 1 a 4 del 1820, a 1 a 13 del 1913, a 1
a 26 del 1959, a 1 a 39 del 1989”[3].
Secondo Officina[4],
alla base degli odierni fenomeni migratori, troviamo proprio
l’impoverimento progressivo dei paesi che tutt’oggi subiscono le
espropriazioni di materie prime e di valore-lavoro attraverso lo scambio
diseguale del neoimperialismo, nonché la quasi impossibilità di tali
paesi di risanare le proprie economie per via della difficoltà
dell’accumulazione dovuta alla concentrazione di un capitale fisso dalle
dimensioni gigantesche nei paesi imperialisti più forti; è da queste
leggi generali dell’attuale fase capitalistica che discendono le
determinazioni concrete che fanno da cause immediate alle migrazioni: la
fame, la povertà, le guerre, la carestia, i disastri “naturali” e chi
più ne ha più ne metta. Per andare maggiormente in profondità col
ragionamento, ancora una volta, siamo “costretti” a tornare a Marx: c’è
una linea di continuità che, aldilà delle specificità presenti, unisce
virtualmente i contadini cacciati dalla proprie terre nell’alba del
capitalismo e radunatisi nelle città, gli artigiani strappati ai propri
strumenti e immessi sul mercato del lavoro, gli africani deportati nelle
piantagioni di cotone, i coolies ingannati con false promesse di
benessere, gli indios trasferiti dall’encomienda alla mita,
gli irlandesi che si lasciarono alle spalle la propria isola e i ghanesi
che oggi oltrepassano il Sahara e il Mediterraneo, così come i messicani
che aggirano il muro al confine con gli
usa e gli arabi che
tentano la fortuna in Occidente: il non rapporto con la
proprietà, l’essere un prodotto umano delle accumulazioni capitalistiche
che gli hanno imposto il lavoro delle proprie braccia come unico bene di
cui disporre e che li hanno costretti allo spostamento, apertamente
forzato o indotto con violenza indiretta, verso i luoghi produttivi
bisognosi di carne da macello. Possiamo a questo punto provare a
collegare diversi aspetti del ragionamento che interessano la
definizione economico-sociale, nonché giuridica, delle persone con la
nozione di proprietà e la definizione in base a quest’ultima delle
migrazioni. Se lo sfruttamento in questi secoli ha assunto forme
particolari e diverse, come lo schiavismo o il lavoro salariato, va
sottolineato anche un comune denominatore: il rendersi del lavoro
dell’espropriato una conditio sine qua non
della legittimità e del
riconoscimento “legale” della sua persona. Marx ha sottolineato
come l’accumulazione originaria, permettendo la concentrazione della
proprietà, produsse una moltitudine di poveri che non riuscì ad
integrarsi nei nuovi meccanismi produttivi soprattutto per la scarsa
capacità di assorbimento di questi ultimi; la sottrazione della
proprietà portò dunque ad una compressione della libertà di circolazione
e ad una loro formale inferiorizzazione che rendeva legittima su
di essi l’inflizione di torture, sofferenze e maltrattamenti sfociando
finanche in alcune forme di schiavismo: Marx registrò «in tutta
l’Europa occidentale una legislazione sanguinaria contro il
vagabondaggio. I padri dell’odierna classe operaia dovettero subire in
un primo momento la punizione per essersi trasformati, contro la propria
volontà, in vagabondi e in straccioni». Sotto il regno di Enrico
vii i mendicanti inabili
al lavoro ricevevano licenza di mendicare, mentre «ai vagabondi robusti
vengono invece riservate frusta e prigione». Enrico
viii invece stabilì,
attraverso uno statuto del 1547, che «qualora una persona si rifiuti di
lavorare deve essere data come schiavo a colui che ne ha denunciato
l’accattonaggio», il quale «ha il diritto di obbligarlo a qualsiasi
lavoro, anche il più ripugnante, con frusta e catena»[5].
È stridente il confronto tra questa detrazione del riconoscimento
giuridico della libertà di movimento con la tradizione liberale che,
negli stessi secoli, teorizzava ed applicava a livello normativo lo
jus migrandi: Luigi Ferrajoli sottolinea che da importanti pensatori
come Locke e Kant, così come da varie legislazioni europee, il diritto
alla migrazione è stato riconosciuto in base al conferimento di un mondo
comune da parte di Dio agli uomini, consentendo quindi anche repressioni
di chi tra questi vi si opponesse: in tal modo il mondo borghese trovava
la legittimazione delle proprie colonizzazioni; oggi però ci troviamo in
una situazione differente perché «dopo cinque secoli di colonizzazioni e
rapine non sono più gli occidentali ad emigrare nei paesi poveri ma sono
al contrario le masse di affamati di quei medesimi paesi che premono
alle nostre frontiere. E con il rovesciamento dell’asimmetria si è
prodotto anche un rovesciamento del diritto”[6].
Emerge qui tutta la contraddittorietà del diritto liberale tra la sua
pretesa universalità e la parzialità della sua applicazione dovuta
all’aver posto la proprietà come proprio principio-base: in un discorso
che procederà in una prospettiva differente rispetto alla traiettoria
che stiamo percorrendo, Negri ed Hardt fanno comunque riferimento alla
definizione del concetto di individuo definito tale non dall’essere
ma dall’avere, rivelandosi quindi un concetto «di natura
superficiale, l’individualismo possessivo e proprietario» dietro il
quale si nascondono i rapporti di forza e i soprusi che hanno forgiato
la società, stigmatizzati dal diritto del capitale come degli a
priori[7].
L’intreccio tra povertà dovuta alle espropriazioni, sfruttamento e
diritto lo rinveniamo anche nel caso dei coolies orientali che,
se sprovvisti di contratto di lavoro, cadevano sotto la schiavitù del
debt bondage, ossia un debito da cui erano obbligati a sollevarsi
tramite il lavoro; lo sfruttamento sotto forma di schiavitù subìto dagli
africani deportati, invece, non aveva nemmeno questa parvenza di
legalità fornita da un contratto, ma in ogni caso anche qui il lavoro
era l’unico riconoscimento legittimo dovuto all’essere umano. Il punto è
che il ricatto del legame del riconoscimento legale-giuridico della
persona con l’accettazione dello sfruttamento e del lavoro salariato
ancora oggi caratterizza il capitalismo, nella sua fase della
totalizzazione. Tra gli esempi più avanzati, purtroppo, possiamo
citare l’Italia con la sua legge n. 189/02, più nota come Bossi-Fini
che ha istituito il «legame tra permesso di soggiorno ed il
contratto di lavoro. In sostanza, si ha “diritto” ad ottenere, [ci
correggiamo]: si ha la possibilità di ottenere un regolare permesso di
soggiorno per lavoro solo se si è in possesso di un regolare
contratto di lavoro». Dunque, «non si può parlare in senso proprio di un
diritto al permesso di soggiorno»[8].
Nel 2009, con l’approvazione del
cosiddetto “pacchetto sicurezza”, l’immigrazione clandestina diviene
reato punibile con un’ammenda dai 5.000 ai 10.000 euro: «nella versione
più recente il reato è passato da delitto a contravvenzione e non
comporta più una pena detentiva, ma si somma al respingimento disposto
dal questore o al provvedimento amministrativo di espulsione»[9].
Le espulsioni, così tanto spesso rivendicate dal Governo Italiano come
un risultato storico contro l’immigrazione clandestina, in realtà
proseguono con numeri davvero molto discreti e solamente verso paesi con
i quali l’Italia è riuscita a stipulare degli accordi, che non sono
molti; nel caso in cui le ambasciate non riconoscano un proprio
cittadino, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, i fogli
di via e le intimazioni a lasciare il territorio nazionale sono
destinati a restare dei dati numerici senza nessuna attuazione. A questo
punto emerge l’analogia generale tra le condizioni degli immigrati in
Italia con quelle dei lavoratori citati in precedenza: il rapporto di
lavoro salariato, schiavista o una loro combinazione ma comunque
reso necessario dalla separazione con la proprietà, è alla base del
riconoscimento formale della possibilità di risiedere legalmente in un
dato territorio. La mancanza del documento, del contratto o in ogni caso
del rapporto di lavoro, nel capitalismo non genera, nella stragrande
maggioranza dei casi, l’effettivo rimpatrio della persona o l’immissione
nei circuiti produttivi al livello contrattuale previsto, ma la
discesa su uno scalino inferiore delle sue
possibilità contrattuali e quindi delle sue condizioni di lavoro.
È per questo che va stigmatizzata la credenza che relega il problema
degli immigrati ad una questione di diritti di cittadinanza: la
sua, come quella di tutti gli altri soggetti sfruttati dal regime
capitalistico, è una questione di classe.
Il ruolo
dello Stato e il problema del razzismo
Quanto asserito finora va dunque a
confermare l’importanza del ruolo dello Stato sostenuta da Officina:
la nostra ricerca quindi va adesso volgendosi all’intima connessione tra
l’esercizio del potere statale da parte del capitale e le diverse
manifestazioni del fenomeno razzista volte alla discriminazione di
spezzoni del proletariato tramite la sua stratificazione e,
simultaneamente, all’attacco indiscriminato nei suoi confronti.
Entrambi questi fattori si sono spesso
presentati sin dalla generazione del rapporto di capitale in varianti
concrete sempre diverse col rafforzamento di luoghi comuni già esistenti
o con discriminazioni create ad hoc direttamente dal capitalismo
in base a vari criteri, dalla razza alla nazionalità passando per
l’etnia, la cultura religiosa, il genere e tante altre. La
gerarchizzazione dei lavoratori, dunque, è una storia vecchia almeno
quanto lo è il capitalismo: Engels ebbe modo di sottolineare gli effetti
deleteri della concorrenza tra lavoratori inglesi e quelli irlandesi
immigrati in Inghilterra. Questi ultimi «hanno scoperto […] quale sia il
minimo dei bisogni dell’esistenza e lo vanno insegnando agli operai
inglesi». Gli irlandesi vivevano in condizioni di estremo degrado e
sovraffollamento, si adattavano a qualsiasi mansione a qualsiasi
condizione accettando un salario notevolmente inferiore rispetto agli
inglesi, eppure «il rapido sviluppo dell’industria britannica non
avrebbe potuto effettuarsi se nella numerosa e povera popolazione
dell’Irlanda l’Inghilterra non avesse avuto una riserva (di manodopera)
di cui disporre»[10].
Probabilmente sono situazione del genere che hanno ispirato le linee
generali della Prima Internazionale ai riferimenti espliciti verso
l’importanza della solidarietà, alla fraternità e al
mutuo soccorso tra i diversi comparti produttivi di un paese nonché
tra le classi operaie di diversi Paesi; questi sentimenti avrebbero
dovuto generare un atteggiamento maturo della classe anche di fronte
alla prontezza di capitalisti di usufruire «nei casi di sciopero o di
chiusura delle officine, […] di operai stranieri come strumento per
soffocare le giuste lagnanze dei lavoratori indigeni»[11].
Ma il razzismo, nella sua duplice funzione di scomposizione e
livellamento verso il basso della classe, non si è rivelato utile
solo tra i “liberi” lavoratori salariati: Marx infatti ne evidenziò
l’efficacia in merito allo schiavismo scrivendo che «alla schiavitù
dissimulata degli operai salariati in Europa occorreva il piedistallo
della schiavitù sans phrase
nel nuovo mondo»[12].
Si potrebbe sostenere che lo schiavismo
rappresenti una forma arcaica di sfruttamento che il capitalismo ha
sconfitto proprio con la sostituzione dello schiavo col “libero”
salariato, ma sappiamo come lo schiavismo sia stato un motore propulsivo
dello sviluppo capitalistico, senza contare che nei secoli più recenti
abbiamo avuto nuovi esempi di “integrazione” tra lo sfruttamento
capitalistico e l’oppressione schiavistica, di cui il caso più eclatante
probabilmente resta quello nazismo[13].
Non vale neanche l’eventuale obiezione che mira ad “isolare” il nazismo
dalle forme di produzione capitalistica, per cui l’ultima rimostranza
che ci si potrebbe rivolgere potrebbe sottolineare l’impossibilità di
ricollegare al presente la storica applicazione capitalistica del
razzismo, per via della recente sconfitta di quest’ultimo: in verità,
alcuni autori argomentano come le motivazioni biologiche della diversità
tra le razze stiano cedendo il passo ad un’evoluzione culturale di un
“razzismo pseudo-antirazzista” che riconosce formalmente pari dignità a
tutti i popoli, salvo teorizzarne l’incompatibilità nella convivenza
(sarà per questo motivo che oggi la maggior parte degli odierni discorsi
razzisti iniziano con l’espressione ormai convenzionale «Io
non sono razzista, però…»). Sono sempre più frequenti le
dichiarazioni di vari leaders mondiali che sembrano avallare la
tesi della storicizzazione del razzismo che segna il passaggio
del crisma dell’inferiorità dall’ambito biologico a quello culturale e
morale: basti pensare alla proclamazione nel 2001, da parte di
Berlusconi, dell’Occidente quale “civiltà superiore” rispetto al mondo
islamico, di cui una parte sarebbe rimasta «al 1400»[14].
Eppure, dichiarazioni come questa non sembrano poi così distanti ad
esempio dallo spirito, descrittoci da Del Boca, con cui l’Italia si
apprestava sul finire dell’800 alle “imprese” coloniali: essa «cercava
di imporsi esibendo il proprio splendido
passato di portatrice di civiltà» e con questa mistificazione giustificò
il suo ingresso nella «battaglia tra la civiltà e la barbarie»[15].
Se da un lato corrisponde a verità l’approdo del razzismo anche
sulla sponda “culturale”, dall’altro crediamo che esso non abbia ancora
tagliato tutti i ponti con la presunzione di supremazia biologica e che
dunque i confini tra razzismo biologico e culturale oggi non siano già
così netti. L’esempio italiano è ancora particolarmente loquace in
merito: con la legge n. 94/2009 «per la prima volta dopo la leggi
razziali del 1938 è stata penalizzata, con l’introduzione del reato di
immigrazione, una condizione personale di status, quella di
immigrato clandestino». Questo è un pericoloso segnale che contraddice
l’idea di un razzismo che sorge come presa d’atto dell’incompatibilità
giacché la preventiva invece a priori andando a punire ciò
che si è e non ciò che si è fatto[16].
L’ambiguità più evidente la troviamo
nella convinzione, spesso ostentata da alcune potenze occidentali (usa
in primis, ma anche dallo stesso Berlusconi in occasione della
dichiarazione di cui sopra), di essere stati investiti dalla Storia del
compito di “civilizzazione” di culture e territori differenti.
Probabilmente ancora non esiste un preciso nucleo enunciativo
dell’affermazione del razzismo: il suo baricentro, piuttosto, fluttua
tra la secolarizzazione delle determinazioni dell’inferiorità di
popoli (in primis della cultura) ed una concezione
teleologica-finalistica della Storia, in cui si va a realizzare questa
gerarchizzazione: in pratica, qui torniamo alla considerazione
idealistico – hegeliana della Storia come mattatoio in ultima
istanza giustificabile[17],
arrivando a considerare l’inferiorità dei popoli quasi come risultato
delle specifiche incarnazioni di un simil - Weltgeist, uno
Spirito del Mondo. In questo modo la parabola teorica del razzismo è
come se “risalisse il fiume” facendo il percorso a ritroso e tornando,
così, a supportare latentemente anche il razzismo biologico. Contro
questa possibile deriva è importante lottare ancora per l’affermazione
di una concezione materialistica della storia in grado, nel caso della
nostra ricerca, di individuare motivazioni e funzioni
delle migrazioni nell’odierno rapporto di capitale. Tutto ciò ci riporta
al tema iniziale, ossia all’importanza del ruolo ricoperto dallo Stato,
testimoniata anche dalla maggiore importanza che riveste il razzismo
istituzionale rispetto quello popolare: specchi empirici di
questa ipotesi sono rintracciabili nell’ascesa, negli ultimi decenni, di
partiti esplicitamente razzisti dall’Austria all’Ungheria passando per
l’Italia, l’Olanda, la Francia, la Gran Bretagna e tanti altri, e
soprattutto nel continuo inasprirsi delle politiche contro gli immigrati
da parte di qualsiasi tipo di Governo. Ci siamo già soffermati sul
particolare contesto italiano e sulle crescenti persecuzioni che il
potere legislativo infligge ai migranti: la possibilità che questa
politica sia davvero volta a fermare l’immigrazione appare sempre meno
credibile; questi filtri legislativi posti dallo Stato, invece,
sembrano piuttosto predisposti per generare una metamorfosi della
merce che gli immigrati rappresentano, ossia una robusta e giovane
forza lavoro. Questo ragionamento rientra appieno in quello dello
scambio diseguale, visto che oggi una merce assume un differente valore
soprattutto in base all’Individuo Produttivo Sociale che va ad
alimentare. Potremmo dire che la legislazione in materia di
immigrazione, che le varie potenze vanno sviluppando, non è altro che un
processo di lavorazione eseguito direttamente sul valore di scambio
della merce che conserva la sua forma fenomenica precedente a tale
processo. Riportiamo il nostro discorso sull’esempio concreto italiano:
l’assenza di canali di ingresso regolari, il legame tra permesso di
soggiorno (pds) e
contratto di lavoro, la criminalizzazione della clandestinità, le
frequenti incompetenze delle Commissioni volte al riconoscimento della
protezione internazionale, l’assenza di sanatorie generalizzate da ben
dieci anni, la riduzione delle possibilità contrattuali: sono questi
alcuni degli arnesi con cui l’IPS italiano incorpora
questa nuova merce e ne moltiplica le possibilità di valore rendendo
ricco ciò che restando nel proprio paese di origine sarebbe rimasto
una merce povera, dotata di scarsa possibilità di valorizzazione
nel complesso del sistema produttivo rispetto quella che esprimerà al
termine di questa metamorfosi. Sono anche questi gli effetti dello
scambio diseguale. Gioiscono molti
italiani quando il mondo della politica presenta nuove misure repressive
contro gli immigrati, senza comprendere che le condizioni di lavoro e di
esistenza degli “ultimi” non sono mai staccate dal resto della classe
ma, anzi, spesso vanno a mostrare possibili condizioni generali in caso
di eventuali peggioramenti della situazione. Tanto per fare un esempio,
recentemente vari paesi hanno reso l’immigrazione sempre più un problema
di ordine pubblico e di sicurezza sfoderando, tra gli
altri, anche «mezzi e metodi militari» che riscuotono spesso l’applauso
ed il consenso degli autoctoni anche se «potranno essere usati domani, e
già cominciano ad esserlo», contro di essi[18].
Possiamo quindi andare a definire il razzismo, nella sua forma più
pericolosa, ossia quella istituzionale, come «componente
potenziale di una ideologia funzionale a questa fase nuova, nella quale
il capitalismo vive una accelerata espansione dei propri rapporti di
sfruttamento»[19].
Esso realizza le condizioni per una profonda stratificazione in
seno al proletariato che, sollecitato ad immaginare l’idilliaca quanto
improbabile situazione di prosperità senza immigrati, non si accorge di
un suo arretramento complessivo dell’impiego delle sue funzioni nel
rapporto di capitale: è su queste funzioni differenti che ora
concentriamo la nostra attenzione.
La funzionalità degli immigrati nei circuiti del lavoro “nero” e del
“non lavoro”
L’epoca della totalizzazione si
caratterizza con una complessità sempre maggiore del capitale costante
che genera la trasformazione, prevista da Marx, «del lavoro vivo in
semplice accessorio di queste macchine, mezzo della loro azione. […] il
capitale riduce qui, senza alcuna intenzione, il lavoro umano (il
dispendio di forza) ad un minimo»[20].
Ma se da un lato il capitale con l’estensione in profondità del suo
rapporto rende il lavoro umano sempre meno determinato concretamente e
sempre più astratto, dall’altro lo stesso lavoro umano, di fronte ad un
complesso macchinico enorme, diventa sempre più insignificante: ciò
spinge il capitale di fronte un’ulteriore contraddizione: esso respinge
la forza lavoro aumentando la propria composizione organica e a un tempo
la attrae perché ne ha bisogno quale unico strumento per la
valorizzazione di questa massa imponente di lavoro morto. È evidente,
perciò, come il capitalismo ormai viva sempre sul filo della crisi:
«nella sua essenza (il capitale) è dotato di un potere illimitato, […]
nella sua esistenza, invece, questo incredibile potere si rivela privo
di sbocchi possibili»; la massa e l’efficienza del capitale costante
rendono il valore dell’ora di lavoro potenzialmente enorme, ma la
concretizzazione nelle merci di questa energia è sempre inferiore alle
aspettative, sempre minore dell’estrazione potenziale di valore dal
lavoro: «questa inadeguatezza del capitale effettivo [le merci] rispetto
alla potenza produttiva generale [il lavoro] è null’altro che la forma
definitiva assunta dalla contraddizione latente tra forze produttive e
modo di produzione»[21]
Tale squilibrio emerge dal rapporto annuale della Federal Reserve,
secondo la quale il pil
mondiale nel 2010 è stato di 74 mila miliardi di dollari, mentre il
mercato obbligazionario conta 95 mila miliardi di dollari, le borse del
pianeta 50 mila miliardi e i loro derivati ben 446 mila miliardi, per un
totale astronomico di 591 mila miliardi di dollari, ben otto volte il
dato dell’economia reale[22]
Dall’analisi di una sproporzione così acuta emerge il ruolo del
doppio mercato del lavoro, ossia l’affiancamento al lavoro regolare
da parte del cosiddetto lavoro nero, ritenuto spesso come
un’altra di quelle imperfezioni che, col tempo, saranno estirpate dallo
sviluppo del capitale. Secondo Officina «esso è invece
necessario, come lo è per noi l’ossigeno all’aria, al processo di
produzione capitalistico, anche a quello ultramoderno della
totalizzazione del rapporto di capitale»[23].
Anche qui l’Italia ricopre un posizione particolare, come possiamo
notare dai seguenti dati:
Grafico 1
– % Incidenza del lavoro sommerso sul
pil italiano e sulla media
dei psa europei
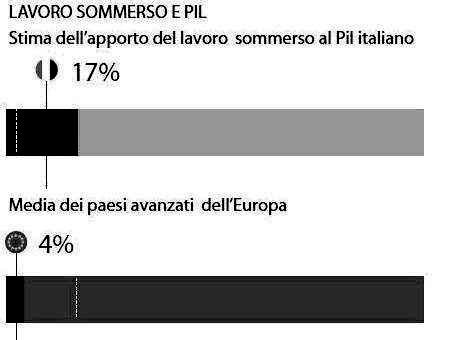
Fonte:
Carcere contro i caporali, Il
Sole 24 Ore, 18 Agosto 2011;
Il lavoro “nero” non è
quindi uno degli aspetti perfettibili del capitalismo ma una sua
caratterizzazione costante che spesso si interseca con l’immigrazione:
la gerarchizzazione del proletariato esprime esattamente la
distribuzione dei suoi spezzoni nei vari comparti produttivi la cui
funzione generale è quella di bilanciare le varie tendenze
all’interno dello sviluppo capitalistico che, a seconda della sua
fase presente, «necessita di
un determinato equilibrio tra le sue componenti del lavoro “regolare”,
del lavoro “nero” e del “non lavoro”».
La prima tipologia di lavoro, infatti,
consente la pianificazione della produzione e prova ad inquadrare il
mercato e la concorrenza in delle regole e dei punti fermi; il lavoro
“nero” invece «velocizza i tempi di accumulazione ed il conseguente
ciclo di rinnovamento del capitale»[24]
ed infine il “non lavoro” concede al capitalismo il tempo necessario per
il rallentamento della produzione con lo scoppio delle crisi e le
successive ristrutturazioni. Perciò anche il lavoro “nero” e la
disoccupazione sono fenomeni contingenti nel capitalismo solo per quanto
concerne la loro composizione qualitativa e quantitativa, perché dal
punto di vista strutturale essi sono imprescindibili per il modo
di produzione capitalistico; nella fase attuale di totalizzazione del
capitale, la disoccupazione permane nella sua funzionalità di “esercito
di riserva” mentre il lavoro “nero” copre il ruolo specifico di
contrappeso nello squilibrio tra il valore produttivo potenziale e
quello effettivamente realizzato: con le grandi porzioni di
plusvalore dedotte dal lavoro “nero” avviene un recupero del valore
complessivo generato dal lavoro vivo, necessario per via dell’aumento
della composizione organica del capitale che rende il lavoro “nero”
«l’unica possibilità di moltiplicazione reale della massa del lavoro
vivo complessivo dentro questa nuova situazione di composizione tecnica
del lavoro. Proprio la dilatazione del sistema macchinino informatizzato
e robotizzato recide, infatti, le normali possibilità occupazionali»,
per cui il lavoro “nero” diventa «il correttivo oggettivo del processo»[25].
Andiamo adesso a collocare quest’analisi teorica nel contesto della
recente crisi economica, con particolare riferimento alla situazione
italiana: nel 2006 l’agenzia dell’UE Eurofound stimava all’8%
l’incidenza nella popolazione dai 18 anni in su da parte dei working
poor, ossia di lavoratori che percepiscono un reddito inferiore al
60% della media nazionale, vivendo, di fatto, nella povertà. I paesi con
le percentuali più gravi erano la Grecia (14%), la Polonia (12%), la
Spagna (11%) e poi l’Italia, la Lettonia e il Portogallo (10% per
ciascun paese)[26].
In Italia, così come nel resto dell’ue,
il rischio di povertà aumenta sensibilmente in proporzione alla crescita
della precarietà del lavoro che qui può essere dovuta al numero di mesi
di lavoro nell’anno, e al contratto a tempo determinato e ai
part-time:
Tab. 1
– In-work poverty risk, by job characteristics of employed population
(18 years and over), 2007 (%)
|
|
Months
worked in year |
Full-time
or
part-time |
Type of contract |
|||
|
|
Full year |
Less than full year |
Full time |
Part-time |
Permanent
contract |
temporary
contract |
|
EU25 |
8 |
15 |
7 |
12 |
5 |
13 |
|
EU15 |
8 |
15 |
7 |
11 |
5 |
13 |
|
IT |
9 |
18 |
9 |
14 |
16 |
19 |
Fonte: Eurofound, Working poor in
In questi anni di crisi il ricorso a
tali forme precarie dell’attività lavorativa è andato sempre più
intensificandosi; osserviamo i dati Istat relativi all’Italia:
Grafico 2
– Occupati per tipologia lavorativa in Italia, periodo 2009 – 2010
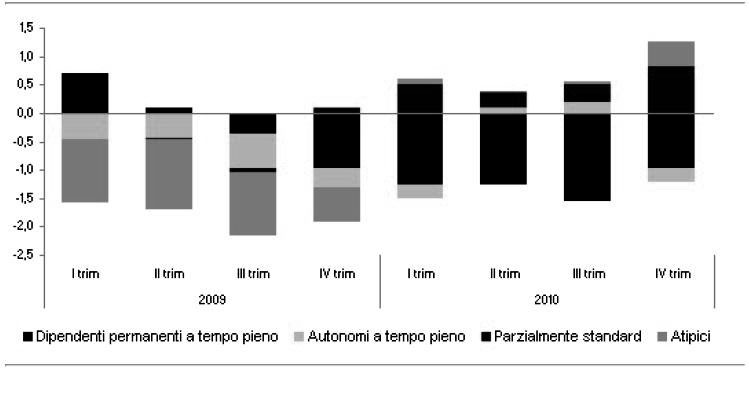
Fonte:
Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, 27 maggio 2011.
La situazione dei giovani
è anche peggiore:
Grafico 4
– Permanenze e flussi in uscita dall’occupazione atipica 18 – 29 anni,
2007
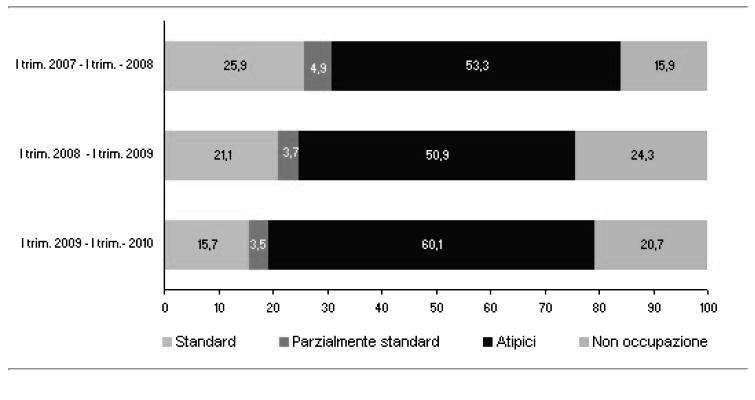
Fonte:
Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, 27 maggio 2011.
Scrive l’Istat nel suo Report 2010
La povertà in Italia: «si conferma la forte associazione tra
povertà, bassi livelli di istruzione, bassi profili professionali (working
poor) ed esclusione del mercato del lavoro»[27].
Ultimo dato a cui si vuol fare riferimento è quello della
disoccupazione: i dati ocse
indicano una disoccupazione giovanile italiana al 27,86% rispetto al
20,29% del 2007 (prima della crisi) e soprattutto rispetto la media
ponderata del 16,7% degli altri paesi dell’area
ocse, dove comunque
risulta aumentata, dal 2008, di 13,4 milioni di unità[28].
Seguendo la riflessione di Officina indicante la necessità di
continui bilanciamenti dell’economia capitalista a seconda dei
vari momenti, in questa fase di crisi il capitale, prima ancora che
potenziarsi, sta dunque rallentando la produzione per affrontare una
propria ristrutturazione, pertanto la bilancia del lavoro pende
decisamente verso la sua minore regolamentazione possibile e la
sua estrema flessibilità: siamo in un processo di «egemonizzazione
nel processo di valorizzazione da parte del lavoro “nero”, “irregolare”,
precario perciò nelle sue varie forme, legali o meno», a
tal punto che un segmento dei lavoratori sempre più consistente vede la
sua posizione lavorativa formalmente “regolare” ma nella sostanza più
vicina al lavoro “nero”, più simile ai working poor, e dunque
vede sfumare sempre più i contorni già labili che la distingueva dall’esercito
di riserva: essi non sono precisamente né l’uno né l’altro, e al
tempo stesso sono entrambi. Procediamo a questo punto a mettere in
evidenza un ulteriore compito che spetta a questi tipi di lavoro
caratterizzati dalla disomogeneità e dalla discrezionalità: l’impiego di
solo lavoro “regolare” da parte del capitale rischierebbe di appiattire
la produzione su degli standard relativamente molto simili, generando un
rallentamento di fondo dei tempi e del volume della crescita
capitalistica. In sostanza, l’accumulazione di un grande capitale
generale necessita anche di valorizzazioni immediate che il lavoro
“regolare” non può dare agli stessi livelli del lavoro “nero”; allo
stesso tempo, la velocità con cui quest’ultimo “brucia” il capitale
accumulato valorizzandolo renderebbe difficile una concentrazione di
ricchezza quale quella a cui stiamo assistendo: «ciò taglierebbe le
gambe, in poco tempo, all’intero sistema, perché la valorizzazione
dipende non solo dal lavoro vivo, ma anche dal grado di concentrazione
del “lavoro morto”». Dunque, il doppio mercato del lavoro
«contribuisce in modo decisivo all’accumulazione effettiva, poiché
salvaguarda il dinamismo e la concentrazione», il che significa che
«sempre, nella società capitalistica ci sarà il comparto del lavoro
sottopagato, con meno normative e con meno garanzie. I soggetti più
deboli della società occuperanno quel comparto: le donne, i giovani, gli
immigrati. I luoghi dove esso si concentrerà saranno quelli a maggior
carenza di struttura produttiva e sociale: in Italia, il meridione»[29].
A sostegno di questa tesi presentiamo di seguito dei dati comparsi su
Il Sole 24 Ore del 18/08/2011:
Figura
1
– Il lavoro “sfruttato” in Italia, 2011

La precedente citazione e la Figura 1
si rivelano a questo punto decisivi nell’indicare il percorso alla
nostra ricerca che va sempre più stringendosi, come indicato all’inizio
del paragrafo, sulle zone del Sud Italia ed in particolare, sulla
“Castel Volturno Area”. Prima di seguire questa traiettoria, però, si
vuol mettere in evidenza un ultimo aspetto generale del rapporto tra
migrazione ed attuale rapporto di capitale: lo spreco di uomini.
Lo “spreco di uomini”
Questa prassi è sempre stata
appannaggio del capitale in due forme generali: l’eccessiva “spremitura”
della manodopera che la conduce ad un logoramento prematuro ed il
sottoutilizzo dello stesso essere umano, impossibilitato dallo
stesso sistema ad “integrar visi” perché bandito dalle leggi e dalla
società per non avere un lavoro oppure “arruolato” come soldato in prima
linea nell’esercito di riserva. Questa peculiarità del
capitalismo va riportata adesso alle caratteristiche della
totalizzazione del rapporto di capitale: in questa fase permane lo
spreco umano per via del supersfruttamento, indifferentemente dal
suo impiego nei comparti centrali della produzione (pv relativo)
o in quelli periferici (pv assoluto), ma si genera anche una
dimensione più profonda di «mortificazione dell’umano» che, secondo
Officina, «assume (secondariamente) la forma del circuito
disoccupazione – lavoro nero» e «(principalmente) la forma di una
generalizzata cultura e pratica metropolitana della morte» che «avvicina
spaventosamente vita e morte, quartiere e carcere, lavoro e precarietà,
isolamento sociale e individuale»[30].
Lo spreco che si consumava nelle fasi del libero mercato e dei monopoli
aveva il carattere della funzionalità: l’estrazione massiccia di
plusvalore da un lato, la pressione al ribasso sul mondo del lavoro
dall’altro; oggi questo spreco di uomini si rivolge anche ad
esseri umani che non rientrano nei circuiti produttivi del capitale
neanche indirettamente: per questo il loro è uno spreco
assoluto. Pensiamo a quella «frazione del ceto contadino bloccato
alla periferia urbana» descrittaci da Fanon, «uomini che la popolazione
crescente delle campagne e l’esproprio coloniale hanno portato a
disertare la terra familiare» e che «girano instancabilmente attorno
alle diverse città, sperando che un giorno o l’altro si permetterà loro
di entrarvi»: questo è il popolo delle bidonville «simile a una
muta di topi» che «non riuscendo a piazzarsi sul mercato, rubavano, si
davano al vizio, all’alcolismo ecc.»[31]:
il capitale va sprecando questi uomini, non molto diversi dal
Lumpenproletariat che oggi si condensa attorno alle metropoli del
“nord” e soprattutto del “sud” del mondo, fatto di generazioni tagliate
fuori da ogni prospettiva e vittime della criminalizzazione della
tossicodipendenza, protagonisti degli scontri tra bande e della piccola
illegalità. Nella nostra attuale società, per via della parabola
discensiva delle condizioni generali del proletariato e del progressivo
appiattimento degli ultimi gradini della scala sociale, anche questo
spreco di uomini e la sua equivalenza tra vita e morte che rendono
l’esistenza una graduale marcescenza si vanno estendendo a sempre più
spezzoni di classe e i migranti non sono esenti da tali meccanismi ma
anzi, essi rappresentano il segmento dove lo spreco va
realizzandosi con immediatezza: l’arrivo nelle “cittadelle del capitale”
di un numero nettamente superiore delle necessità del capitale per la
formazione dell’esercito del lavoro nero e quello di riserva (che spesso
coincidono) andrebbero solamente ad approfondire le situazioni di
estremo degrado generando costi più alti di servizi sociali, che invece
il capitale spinge verso sempre più drastiche riduzioni, e maggiori
spese per la repressione. Per scongiurare questi inconvenienti, il
capitale preferisce lasciar morire queste persone durante il loro
viaggio: esse sono più utili da morte, da scomparse, da affogate
piuttosto che come vive complicazioni. Potremmo fare l’esempio
degli usa e della loro
operazione Gatekeeper consistente nell’innalzamento di un muro di
recinzione con la frontiera messicana e supportata poi dall’aumento di
controlli, rastrellamenti e pattugliamento anche da parte di cittadini
volontari, il cui brillante risultato non è stata non la fine del
processo migratorio ma una selezione casuale al suo interno che
ha fatto crescere i morti del 500%[32];
L’Europa non è da meno: dal 1988 al 01/08/2011 sono 17738 i morti
registrati nei diversi tentativi di varcarne i confini[33]
ma in questa stima non rientrano le migliaia di morti che
avvengono nel Sahara; l’Italia risulta protagonista di un ulteriore
sistema di spreco umano con i suoi accordi con la Libia
concretizzatosi, sul fronte immigrazione, con una serie di respingimenti
in violazione a tutta una serie di norme nazionali e internazionali[34],
la reclusione dei migranti nelle carceri libiche dove sono sottoposti ad
ogni genere di violenza e maltrattamenti, l’abbandono nel deserto, il
rimpatrio nei paesi da cui si è fuggiti anche per richiedenti asilo:
questi sono i modi in cui il capitale si disfà in modo assoluto della
merce umana in sovrappiù, l’immediato e gratuito spreco degli uomini
alimentato dalle grandi potenze firmatarie di tanti trattati e
convenzioni a difesa dell’essere umano! Il Sole 24 Ore nel
febbraio del 2010 riportato un’inchiesta della società Gallupp, condotta
tra il 2007 e il 2009, i cui dati riferiscono che il 16% della
popolazione mondiale in età adulta lascerebbe il proprio paese: parliamo
di circa 700 milioni di persone[35]:
in caso di aggravarsi della crisi, purtroppo una buona fetta di quanti
si dovessero effettivamente mettere in viaggio sarebbe irrimediabilmente
condannata a non poter neanche arrivare ai paesi di destinazione,
risucchiata dallo spreco assoluto. A questo punto possiamo
rispettare le nostre precedenti intenzioni soffermando la nostra ricerca
sulla “Castel Volturno Area” quale osservatorio di spicco del rapporto
tra migrazioni e dell’esercizio concreto dello sfruttamento nella fase
della totalizzazione.
MARZO 2013
[1]
Cfr. La
totalizzazione del
rapporto di capitale, dello stesso autore, pubblicato sul
numero 09 della rivista [N.d.R].
[2]
P. Basso, Sviluppo diseguale, migrazioni, politiche
migratorie, in P.
Basso, F. Perocco (a cura di), Gli immigrati in Europa -
Diseguaglianze, razzismo, lotte, Franco Angeli, Milano 2008,
pp. 86-87.
[3]
P. Basso, Dalle periferie
al centro, ieri e oggi, in P. Basso, F. Perocco,
Immigrazione e
trasformazione della società, Franco Angeli, Milano 2009, p.
30.
[4]
«Dalla seconda
metà degli anni ’80 fino al 1994 un gruppo di comunisti delle
province di Napoli e Caserta diede alla luce circa una decina di
numeri di una rivista, il periodico marxista
Officina, attraverso la quale espressero
l’esigenza di rivedere alcuni fondamenti teorici che hanno
accompagnato i marxisti nel ‘900 a cominciare
dall’interpretazione leninista del capitalismo come sistema
morente e prossimo alla dipartita». Vedi nota 2 [N.d.R].
[5]
K. Marx, Il Capitale, Newton, Roma 1996, pp 528-529.
[6]
L. Ferrajoli, Politiche contro gli immigrati e razzismo
istituzionale in Italia, in P. Basso (a cura di),
Razzismo di stato, Franco Angeli, Milano 2010, p. 118.
[7]
M. Hardt, A. Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico,
Rizzoli, Milano 2010, pp. 20-21.
[8]
P. Basso, F. Perocco, Gli immigrati in Europa, in P.
Basso, F. Perocco, Gli immigrati in Europa – disuguaglianza…, cit.,
p. 18.
[9]
M. Ferrero, Il “pacchetto
sicurezza”: dall’integrazione subalterna degli immigrati alla
loro criminalizzazione, in P. Basso (a cura di),
Razzismo di stato,
cit., pp. 429-430.
[10]
F. Engels, La situazione della classe operaia in Inghilterra,
Edizioni Lotta Comunista, Milano 2011. pp. 157-159.
[11]
K. Marx, L’internazionale operaia, Editori Riuniti, Roma
1993, p. 37.
[12]
K. Marx, Il Capitale, cit., p. 546.
[13]
Il vero imputato è il capitalismo, in «Officina»
n. 0, giugno 1987, p. 13.
[14]
P. Di Caro, L’Occidente è una civiltà superiore, in «Il
Corriere della Sera», 27 settembre 2001, p. 9.
[15]
A. Del Boca, Italiani, brava gente?, Biblioteca Neri
Pirozza, Vicenza 2008, p. 47.
[16]
L. Ferrajoli, Politiche contro gli immigrati…cit.,
pp. 119 -120.
[17]
G. W. F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, La
Nuova Italia, Firenze 1941, p. 59.
[18]
P. Basso (a cura di), Razzismo di stato, cit., p. 12.
[19]
Il fatto – Maggio ’88, in: «Officina»
n. 3, luglio – settembre 1988, p. 20.
[20]
K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia
politica, quaderno VI, pp. 33 -39, in:
http://www.sitocomunista.it/marxismo/Marx/grundrisse/Marx_Karl_-_Grundrisse_3c__Il_Capitale.pdf
.
[21]
La crisi economica nell’epoca del rapporto totale di capitale,
in «Officina»
n. 9, marzo 1993 p. 13.
[22]
Board of Governors of the Federal Reserve System, 97th
Annual Report, 2010, in:
http://www.federalreserve.gov/publications/annual-report/files/2010-annual-report.pdf
.
[23]
Note sul razzismo, in «Officina
block notes», settembre 1989, p. 5.
[24]
Note sul razzismo,
cit., p. 6.
[25]
Il rapporto totale di capitale, in «Officina»
n. 6, gennaio 1990, p. 10.
[26]
Eurofound, Working poor in
[27]
Istat, La povertà in Italia, 2010, p. 3.
[28]
ocse,
Employment Outlook 2011, in:
http://www.oecd.org/dataoecd/36/27/48622469.xls .
[29]
Note sul razzismo,
cit., p. 6.
[30]
Note sul razzismo,
cit., p. 10.
[31]
F. Fanon, I dannati della terra¸
Einaudi, Torino 2007, pp. 77-78.
[32]
P. Basso, L’ascesa del razzismo
nella crisi globale, in: P. Basso (a cura di), Razzismo
di stato, cit., pp. 19-20.
[33]
Fortress Europe, La strage,
in:
http://fortresseurope.blogspot.com/p/la-strage-negata-17317-mortiai-confini.html
[34]
L. Ferrajoli, Politiche contro gli immigrati…cit.,
pp. 19-20.
[35]
M. Naim, 700 milioni – la più grande emigrazione del secolo,
in «Il Sole 24 Ore», 23 febbraio 2010.
